La magica parola
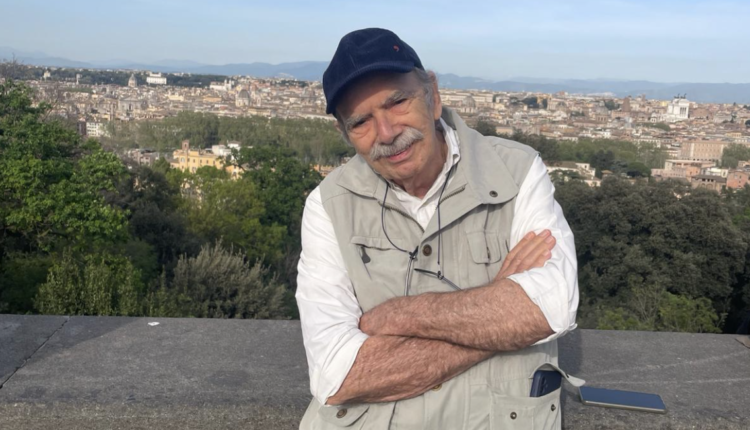
“Noi non riusciamo a spiccare il volo. Non ci riusciamo proprio. E mai più ci riusciremo. Almeno fino a quando non sapremo ritornare bambini, capaci di incantarci e stupirci e vincere contro il vento e la gravità, liberandoci leggeri nei cieli infiniti.”
L’ho scritto qualche giorno fa commentando una poesia di Emilia Cirillo, che ha ricevuto ispirazione (l’ha confermato l’autrice) dalla serata che Koinòs ha dedicato alla canzone umoristica napoletana e, in particolare, al saggio di Benjamin su “Napoli città porosa”.
Tutto ciò mi è tornato alla mente nel leggere l’articolo “Incanti”, pubblicato ieri da Anna Carmen Lo Calzo sul sito di Franco Genzale.
Colpita da uno spettacolo tenuto da sei giovani maghi – ricco di alchimie e suggestioni – affascinata dalla “esperienza dell’incanto” che i talentuosi protagonisti sono riusciti a suscitare, l’autrice si interroga sulla capacità dell’uomo contemporaneo di accedere (o di cedere?) al mondo dei sogni. Lo spettacolo è costruito su potenti rappresentazioni fatte di illusionismo e di magia, ma fatto anche di citazioni pertinenti dei più grandi pensatori dell’era moderna. Tra esse, la Lo Calzo si sofferma, in particolare, su di una frase riferibile allo Shakespeare de “La tempesta”: Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Da qui l’interrogativo che accende i pensieri dell’autrice sulla condizione di incanto che ci può affascinare e sorprendere. Sulla sua vera natura e sull’importanza di saperla coltivare nella nostra vita.
Il passo da questo pensiero alle considerazioni fatte, qualche sera fa, essenzialmente intorno al saggio di Benjamin su Napoli “porosa”, ma anche intorno al fascino misterioso dell’oracolo della Sibilla cumana e, infine, intorno all’affermazione del filosofo tedesco circa l’incertezza come essenza totale dell’esistenza umana, è stato molto breve.
Rispetto a tutto ciò il pensiero della Lo calzo è diverso. Non esiste nel suo scritto tutta quella concretezza, quella materialità, quella carnalità che, pur se in una delicata sospensione tra il vero e l’onirico, marca la dimensione esistenziale del popolo napoletano, alla quale si riferisce il filosofo tedesco. La Lo Calzo vira direttamente verso la terra di frontiera situata tra il sogno e la realtà. Verso quella dimensione “surreale e onirica necessaria, dalla quale spesso fuggiamo per mancanza di tempo, di ispirazione, di introspezione, ma della quale abbiamo sicuramente bisogno.”
Questo discorso non poteva non suscitare in me anche altri pensieri, altre reminiscenze. Questa volta, più che altro, reminiscenze professionali. Mi riferisco alla teoria di Freud sull’interpretazione dei sogni, pietra miliare della psicologia clinica. Ma il riferimento che mi interessa qui riportare non è agli aspetti tecnici dell’opera, quanto piuttosto ad una frase che Freud pone in testa al saggio. Una frase che riporta la citazione di un verso dell’Eneide: Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo. Tradotto in maniera semplificata ma efficace, la frase, pronunciata da una Giunone furente che ha visto giungere nel Lazio – contro il suo volere – Enea, significa: se non riuscirò a modificare il volere degli Dei, scatenerò gli Inferi.
Evidentemente la citazione ha un significato particolare nel pensiero di Freud e si collega al concetto del dualismo esistente tra il mondo cosciente e l’inconscio. Rispetto all’eterna criticità del rapporto tra queste due dimensioni, il pensatore austriaco ha costantemente suggerito la constatazione dell’incredibile potenza della dimensione inconscia della psiche. E la citazione della frase dell’Eneide conferma ciò. Freud, infatti, pone la frase proprio all’inizio del suo saggio, per creare un’analogia tra il fiume infernale dell’oltretomba, che può emergere ed inondare dal profondo, e l’inconscio, che altrettanto può emergere dal profondo ed inondare i nostri sogni. Non soltanto, però. Può inondare e sommergere anche la nostra realtà. Potente immagine, questa, che inverte l’idea millenaria cristiana dell’inferno inteso quale luogo della punizione eterna, per riconoscere invece ad esso una enorme potenzialità creativa e, quindi, positiva e propositiva.
“Qual è la sostanza dei sogni? La risposta a queste domande risiede nell’esperienza dell’incanto” sentenzia Anna Carmen Lo Calzo.
Ed è questa dimensione incantevole ed incantata del sogno che mi ha suggerito un altro ricordo.
Questa volta, lo spunto è letterario e si riferisce ad uno dei massimi poeti della nostra letteratura: Giovanni Pascoli. C’è una sua poesia, che non è certo tra le più conosciute, che non poteva non venirmi in mente. Si intitola “Sogno”. È tratta dalla raccolta Myricae, che è la prima prodotta dal Pascoli e che indica, proprio con questo termine, la volontà del poeta di dare una connotazione di umiltà alla sua produzione. Ed è con un linguaggio apparentemente semplice e dimesso che, in questo breve componimento, il poeta romagnolo racconta un sogno nel quale rivisita le figure dei genitori defunti.
Stanco tornavo… al mio padre, ai morti… Sentivo una gran gioia e una gran pena,
una dolcezza ed un’angoscia muta.
Questa narrazione dà una rappresentazione commossa e delicata del concetto per il quale non esiste una vera e precisa separazione tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Questi due mondi, anzi, si intersecano e, a volte, si ricongiungono. E se, dunque, il sogno rappresenta quel punto sospeso tra realtà e fantasia, tra il vero e l’illusorio, tra la vita e la morte, allora il sogno costituisce la condizione più alta e più completa dell’umano esistere. Consente di riannodare mondi diversi e prova a penetrare fino in fondo il mistero dell’umana natura.
Tra il materialismo scientifico e il misticismo religioso esiste un’area grigia, che si tenta da sempre di esplorare. Un’area che prova a considerare i due estremi rimodulando la loro pretesa di verità inflessibile ed esclusiva. È in questo stato intermedio di vita e di morte che si colloca e si interroga da millenni il pensiero dell’uomo.
Un uomo che da sempre ha sentito il bisogno di esplorare questa terra di confine. Ancora e sempre ignota. Ma comunque sempre suggestiva. Subdolamente accattivante. Affascinante con i suoi misteri. Ed è per questo che, a partire dai miti omerici, passando attraverso i misteri degli oracoli sibillini, le esplorazioni antiche e nuove di poeti e filosofi, di scienziati e maghi, si snocciola un ineludibile percorso dell’uomo che insegue, perennemente ed affannosamente, la ricerca del vero. La ricerca, quantomeno, di quella magica parola che possa concedergli la pace della sua mente e del suo cuore.

I commenti sono chiusi.